Il giornalismo a colloquio dal potere

foto via
Questa settimana il direttore del Guardian Alan Rusbridger è stato convocato presso la Commissione Affari interni della Camera dei Comuni di Londra per partecipare a un’audizione sulle rivelazioni del caso datagate - che il suo giornale in questi mesi ha pubblicato - e sul trattamento e la divulgazione delle fonti. Un lungo colloquio durante il quale Rusbridger ha difeso il lavoro della sua testata e più in generale il ruolo del giornalista 'oggi', in una società globale, iperconnessa, e - come visto - sorvegliata a vari livelli, conquistandosi l’apprezzamento di diversi colleghi. Da quanto emerso dall’audizione, il Guardian avrebbe in suo possesso 58mila documenti, ne avrebbe pubblicati finora solo l’1% (esattamente 26) e non avrebbe intenzione di condividerne molti altri. Tutte informazioni che sarebbero passate al vaglio del sistema di controllo che suggerisce cosa è meglio non pubblicare per questioni di interesse nazionale (il DA-Notice), e che sarebbero arrivate in pagina attraverso il filtro della sua redazione e di quella dei colleghi del New York Times, con la quale sono stati condivisi parte dei leak, con la promessa di omettere alcuni dati sensibili.
La convocazione di Rusbridger è uno di quegli episodi che lascia capire quanto il giornalismo post-Snowden stia subendo una radicale trasformazione, finendo con l’influenzare il modo col quale si lavora sulla notizia (Suzanne Nossel sul sito della CNN, David Sirota su Pando), l’intero panorama dell’industria mediatica (non ultime le novità presentate dallo stesso Pierre Omidyar, futuro editore della newco di Greenwald, questa settimana sull’HuffPost) e il rapporto sempre più conflittuale tra media e politica. In questa sorta di «guerra al giornalismo» (della quale avevamo già accennato) che si è finora espressa attraverso ostacoli e intimidazioni di vario genere, il legittimo e accurato lavoro di disvelamento di notizie di interesse pubblico può essere facilmente messo ‘sotto inchiesta’ (spesso in maniera goffa, come nel caso delle domande dei membri della commissione, apparse a molti piuttosto inadeguate e che hanno provocato più di un commento ironico). Tutti esercizi di influenza del potere provenienti da parte di quegli stessi apparati - come sottolinea lo stesso Rusbridger - che si sono ‘lasciati sfuggire’ quei leak che il giornalismo, ottemperando alla propria missione, pubblica fin dove ritiene legittimo.
L’era post-Snowden
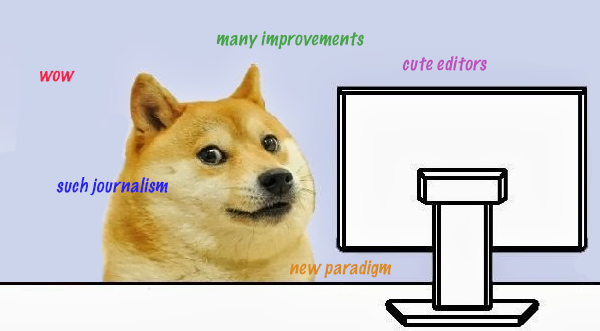
A questa «lezione di libertà di stampa», come l’ha definita Jeff Jarvis su Twitter, ha risposto in una lettera al Guardian Carl Bernstein, fra i due reporter ad aver scatenato lo scandalo Watergate (da leggere il commento su Twitter di Dan Gillmor). Bernstein riprende proprio il tema della conflittualità fra giornalismo e potere, denunciando l’ingerenza «dei governi di Washington e Londra» materializzatasi in questi giorni dalla convocazione alla Camera dei Comuni, un’operazione figlia di un ‘trend’ generale che sembra quasi «erigere serie barriere contro il più legittimo lavoro giornalistico» che si sia mai visto negli ultimi decenni. Ci sono e ci saranno sempre tensioni fra i diversi attori che hanno costruito l’impianto democratico occidentale, conclude il giornalista, ma la sua testimonianza - forte di una storia professionale che affonda al già citato caso Watergate e alla pubblicazione dei Pentagon Paper - è che una stampa veramente libera e senza intimidazioni governative è davvero l’unica forma di controllo contro il dispotismo, la demagogia, il crollo della democrazia «e persino gli atti criminali di rappresentanti e governanti».
Nell’era digitale si assiste alla redistribuzione di informazioni - e quindi potere - che rimette in gioco il metodo attraverso il quale si rendono pubbliche informazioni che servono a raccontare - e controllare - i processi democratici. Alec Ross, ex Senior Advisor per l’Innovazione dell’ex Segratario di Stato Hillary Clinton, ritiene che a questa sorta di «onniscienza» possa far seguito un desiderio di «onnipotenza», da esercitare in modi diversi e molto più sofisticati. In un suo discorso riportato dal blog della London School of Economics di Charlie Beckett, spiega come queste nuove armi - provenienti da un più elevato accesso alle informazioni - possano effettivamente modificare la struttura geopolitica dell’intero pianeta. Forme di sorveglianza, come quelle che si stanno scoprendo in questi mesi, solo qualche decennio fa potevano sembrare inimmaginabili, così come allo stesso tempo sembra quasi impossibile pensare a fenomeni come Wikileaks, che a queste nuove strutture di controllo intendono reagire, quasi fossero anticorpi nati spontaneamente. Va da sé che il concetto stesso di professione giornalistica diventa sempre più essenziale: «L’era dell’informazione non è solo il presente, ma anche il futuro», conclude. Ciò che resta da vedere è come le strutture di potere e di controllo reciproco - come appunto media e governi - si riequilibreranno in un panorama del tutto nuovo.
La bolla della viralità

Da una prospettiva totalmente diversa - quella propriamente industriale e editoriale - la distruzione di uno status quo decennale nel mondo del giornalismo appare ormai ovvia. E nel mondo anglofono, almeno per il momento, è rappresentato da una schiera di portali digital native che stanno minando, in termini di attenzione, investimenti e contatti, l’egemonia delle testate storiche. Questa settimana sul Wall Street Journal Farhad Manjoo ha intervistato Neetzan Zimmerman di Gawker, responsabile dei contenuti 'virali' e portatore, da solo, di una media di 30 milioni di visite al mese, una porzione decisiva delle visite generali dell’intero sito (qui le statistiche pubbliche del sito, per farvi un’idea). A Manjoo, l’editor 32enne racconta il suo metodo di lavoro, incentrato soprattutto sulle intuizioni personali, una sorta di formula quasi inspiegabile che gli permette di capire - aiutato comunque da una redazione e da una capillare rete di fonti online - cosa potrebbe ‘funzionare’ in rete (specie su Facebook) e di insidiare in termini di contatti il ben più blasonato New York Times. Una specie di dono: quando non ne sarò più capace - chiude - «mi troverò qualcos’altro da fare».
Zimmerman avrebbe trovato il «gap for human intuition in an environment dominated by machines», lo stesso intervallo che fa dire a più di un commentatore, in settimana, che il modello di business basato sulla viralità dei contenuti - o meglio, sulla produzione di contenuti pensati esclusivamente per questo obiettivo - non è sostenibile se non a breve periodo (Mathew Ingram). Una struttura produttiva debole (Bryan Goldberg su Pando) incapace di riprodursi con provata efficienza e prevedere su basi empiriche l’effettivo successo di un post, demandando all’intuizione umana tutto il segreto della loro viralità. Stesso problema con gli inserzionisti, ai quali non si possono garantire prestazioni certe né l’effettivo ritorno economico del loro investimento pubblicitario (campagne che quasi sempre richiedono precisione chirurgica e pianificazione). Una sorta di «bolla» (Andrew Beaujon su Poynter) che ha generato in tempi recenti una nidiata di siti votati ai viral content e che sta imponendo un nuovo sistema di rappresentazione delle notizie (Maria Konnikova sul New Yorker questa settimana spiega il perché del successo dei listicle dal punto di vista psicologico). Sempre ammettendo che lo scopo di queste nuove creature sia quello di fare 'giornalismo' (si veda l’esempio di ViralNova riportato da Harry Cheadle su Vice US e Alex Litel su The Wire, o ancora la gaffe di BuzzFeed di questi ultimi giorni).
Newsweek torna in edicola

Una delle notizie della settimana è il futuro ritorno in edicola di Newsweek, settimanale che lo scorso anno aveva abbandonato l’edizione cartacea dopo una storia decennale e che ora, con la nuova proprietà, intende ripresentarsi sul mercato con un prodotto fisico. Un magazine da 64 pagine a partire da gennaio-febbraio, che nelle intenzioni dell’Editor In Chief Jim Impoco vorrebbe diventare un’alternativa a The Economist - modello al quale il giornale si era già rifatto qualche anno fa con discreto insuccesso. Ai suoi massimi, rammenta Christine Haughney sul New York Times, Newsweek ha toccato quota 3,3 milioni di lettori (1991), per poi digradare lentamente verso la cessione (dal gruppo del Washington Post a Sidney Harman, per un dollaro) e alla fusione - mai del tutto riuscita - con The Daily Beast, alla quale ha fatto seguito la recente acquisizione di IBT Media. Il ritorno alla carta, dopo mesi di stop e in uno scenario del genere, è stato definito da Lucia Moses su AdWeek una mossa “controintuitiva”.
In quelle stesse ore il New York Magazine annunciava il taglio nelle pubblicazioni, che lo porterà in edicola solo due volte al mese (e non quattro), con circa 26 numeri e tre edizioni speciali annuali - triste sorte per un giornale simbolo, nella lunga analisi di David Carr sul Times, che parla più in generale di “fine di un’era”. Più ottimista Sarah Green sulla Harvard Business Review, che in post dal titolo «Publisher, Stop Crying Over Ink» spiega che dopo tutto, considerando la crescita di traffico del sito (+19% negli ultimi 8 mesi) e delle entrate derivanti dalla pubblicità su digitale (+15%, con sorpasso da quelle sulla carta atteso nel 2014), il passo indietro in edicola non sarebbe altro che una naturale e lenta evoluzione, e non una involuzione del progetto. Per Carr, sostiene l’autrice, evidentemente «carta < digitale = brutto», quando invece - semplicemente - l’attenzione dei lettori si sta spalmando (e spostando) su più strumenti: «i critici dei media farebbero bene a lasciare a casa i loro sad trombone».



