Questa settimana in RoundUp: al giornalismo manca una figura manageriale, in grado di capire come far funzionare un'azienda che sta sul mercato e regalare un futuro alla professione? In Ucraina, intanto, un sito di debunking di bufale ha raggiunto in poche settimane la media di 1.5 milioni di visite al mese, mentre i media mainstream fanno ancora fatica a citare il materiale user generated. Ai lettori - infine - piacciono le notizie che riportano problemi che prevedano soluzioni, ma forse un po' meno i longform - se è vero che Byliner, una delle più note piattaforme del genere, è in seria difficoltà.
Al giornalismo serve un manager
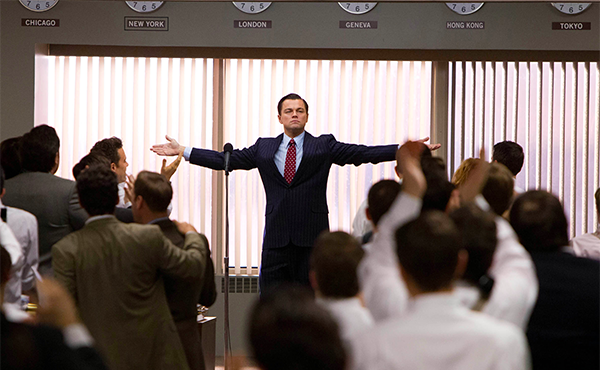
A causa della sua stessa natura, il giornalismo si pone da sempre a metà strada fra il servizio pubblico e l’iniziativa da lanciare e mantenere sul mercato. Questa ambiguità sarebbe uno dei fattori alla base della crisi odierna, specie se associata allo scenario industriale e commerciale imposto da Internet: è la tesi che trova riscontri in un pezzo di Ryan Chittum di questa settimana su The Audit della Columbia Journalism Review, secondo il quale alla classe giornalistica mancherebbe da sempre una vera e propria formazione manageriale, carenza che ne metterebbe continuamente a repentaglio l’esistenza sul mercato malgrado l’evidente funzione sociale. Il problema, secondo l’autore, è che [tweetable]«What makes for a great reporter doesn’t necessarily make for a great boss»[/tweetable] - spiega, citando il recentissimo caso Jill Abramson-New York Times come esempio: il giornalismo, in pratica, è l’unico settore del mercato mondiale nel quale figure del genere esistono raramente, o addirittura non sono previste.
I giornalisti tenderebbero a rifiutare una preparazione di carattere gestionale immaginandosi indispensabili, al di sopra delle dinamiche del mercato, per quel senso «d’indipendenza, scetticismo, aggressività» che anima generalmente il loro lavoro - caratteristiche che dal punto di vista commerciale renderebbero qualsiasi company piuttosto ingestibile. Un manager, tuttavia, è anche una figura fondamentale per aziende, come quelle giornalistiche, che hanno bisogno di coordinare il lavoro di autori, ingegneri informatici, designer, social media manager (le nuove figure redazionali sono numerose e spesso quasi ridicole, come registra Paul Ford questa settimana su Medium), tendendo continuamente l’orecchio alle novità tecnologiche e editoriali (solo in questi giorni il Times ha lanciato una nuova app a pagamento e sta pensando a un futuro meno stampa-centrico, quasi una risposta a questo scenario post-carta immaginato da Steve Outing). C’è bisogno, in pratica, della «persona giusta al posto giusto», qualcuno che metta in discussione l’autorità stessa del giornalista – spiega Jill Geisler del Poynter Institute. Da qui, forse, questa inestinguibile ostilità.
Il sito anti-bufale da 1.5 milioni di visite uniche

Una delle sfide principali, infatti, è prendere le misure a quantità e qualità del lavoro online, farsi strada fra contenuti non verificati, negligenza e bufale, e cercare un equilibrio nel rapporto tra concorrenza-coessenza con gli user generated content. Questa settimana su NiemanLab Lydia Tomkiw ha raccontato la storia di StopFake.org, un sito (in russo e inglese) creato da un gruppo di giornalisti, studiosi e volontari di Kiev che ha l’unico scopo di verificare le informazioni e i multimedia che circolano sui fatti ucraini. Yevhen Fedchenko è il direttore del programma di giornalismo della National University di Kiev che si è chiesto, a inizio 2014, come potesse aiutare a far pulizia nelle migliaia di contenuti falsi che circolano sulla crisi militare del suo paese. A marzo insieme ad altri fonda il sito che adesso controlla materiale proveniente da tutto il mondo, anche con l’aiuto dei lettori (grazie ai social network e la sezione “Report a Fake”), e ha cominciato a servirsi di controlli incrociati e telefonate di verifica come una redazione giornalistica vera e propria: la situazione è complicata, ammette, tanto più per la natura propria dei contesti di guerra, ma la notizia - dal punto di vista più meramente commerciale - è che il sito in soli 90 giorni ha raggiunto il milione e mezzo di visitatori unici mensili.
Se il contributo dei lettori appare fondamentale, però, non del tutto necessaria sembra essere la doverosa citazione del lavoro altrui. Almeno stando a un report del Tow Center for Digital Media, secondo il quale i media mainstream fanno sempre più fatica a citare la fonte dalla quale si è preso il contenuto presentato. Ne scrive questa settimana Mathew Ingram: causa di tutto ciò, spiega, è la mancanza di strutture redazionali «in grado di dedicarsi agli user generated content, ma non solo: deriva anche di una tensione culturale fra giornalisti professionisti e citizen journalist». Secondo lo studio la maggior parte delle news organization, online e televisive, raramente spiega da dove i contenuti provengono, né esiste una vera e propria sistematizzazione del relativo processo di verifica, che appare ancora lontana dall’essere prassi: il 72% degli UGC, continua il report, non ha fonti né descrizioni riconducibili all’autore, e solo il 16% di queste compaiono sui network televisivi. Come spiegato dal CEO di Storyful Mark Little, spesso si considera - erroneamente - che una più generica citazione “da YouTube” o “da Instagram” possa bastare, ignorando totalmente anche le potenziali conseguenze legali.
Cosa ne è del longform journalism?

Riuscire a trovare il prodotto giusto, capace di soddisfare lettori ed esigenze editoriali, resta ancora la sfida più difficile da raccogliere, spesso cercando di governare dati e tendenze impreviste. Stando a uno studio dell’Università del Texas, per esempio, i lettori apprezzerebbero gli articoli che contengono al loro interno sia i problemi che le loro possibili soluzioni - li renderebbero più coinvolgenti, migliorando il feedback di chi legge. Ma in questa continua ricerca, che ha visto nascere e morire i più diversi esperimenti, cosa ne è del longform journalism - già più volte citato in questa rubrica? Un genere di per sé per niente nuovo, se si ammette che la lettura più lunga e profonda non è un’invenzione dell’editoria digitale, ma è comunque una tendenza online che si è fatta strada negli scorsi mesi, con esiti ancora ignoti. Ben Smith su Medium in gennaio la definiva come una strada nuova, se applicata come si conviene ai linguaggi digitali, per raggiungere quel senso di empatia, e quella voglia di condivisione, che molto speso caratterizza - volutamente - le reazioni di chi legge il suo sito, e poi ne condivide i contenuti.
Ma quale futuro per il genere? Di certo si sa che il Guardian si sta avvicinando allo strumento, avendo coinvolto in questi giorni il web editor del New Yorker Jonathan Shainin in un progetto di cui si conoscono ancora pochissimi dettagli, ma che dovrebbe mettere proprio il longform al centro. Meno entusiasmanti invece le cose per Byliner, la piattaforma di e-single - articoli lunghi da comprare individualmente - che sta attraversando, quanto pare, una fase economicamente difficile. Il progetto, nato nel 2011, era partito come iniziativa da tenere d’occhio, come piccolo laboratorio nel quale rivedere la probabile sorte di questo territorio ancora nuovo dal punto di vista digitale (e in questo senso, la partnership del 2012 col New York Times, di cui avevamo già parlato, sembrava un segnale più che promettente). Da una mail pubblicata questa settimana da Paul Carr su Pando (titolo del post: "Bye Bye Byliner") si ricavano però informazioni del tutto diverse: la società starebbe soffrendo (il co-fondatore Mark Bryant, tra l’altro, si era dimesso il mese scorso) e sarebbe attualmente alla ricerca di nuovi partner per continuare a sopravvivere.


