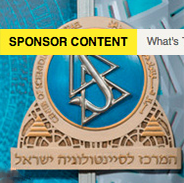Questa settimana in RoundUp quattro storie basate sugli errori: il caso dell'advertorial di Scientology su The Atlantic e i rischi del native advertising, la prima sentenza giuridica a proposito dei diritti d'autore delle foto pubblicate su Twitter, la bufala della morte della ragazza del giocatore di football Manti Te'o e le nuove policy del Washington Post per regolare le correzioni degli articoli online.
The Atlantic e l’advertorial di Scientology
Questa settimana è stata principalmente quella del ‘caso' The Atlantic-Scientology, a causa del dibattito che attorno a esso si è generato e che ha in qualche modo segnato un’inversione di rotta rispetto a qualche settimana fa sul tema del native advertising - definizione che sul finire dell'anno scorso era diventata una sorta di buzzword e considerevole opportunità di uscita dalla crisi della pubblicità in grado di dare una speranza alla sostenibilità economica dell'informazione online. Nonostante ciò, non sono stati pochi in questi giorni gli articoli nei quali si ammonisce dai rischi degli sponsored content (Keller e Beaujon su Bloomberg Businessweek e Poynter), si cerca di trarre una lezione (Ingram su PaidContent) e si enumerano i pro e i contro di questo tipo di inserzioni (si tratta, come già visto, di articoli promozionali impaginati e proposti come un normale post ma segnalati come special advertiser feature, o sponsor content).
Il caso: lunedì scorso il sito della storica rivista The Atlantic ha pubblicato un advertorial (altra definizione per questo tipo di contenuti, da advertising e editorial) dal titolo «David Miscavige Leads Scientology to Milestone Year», ossia «Miscavige - il leader dell’organizzazione - conduce Scientology in un anno cruciale». Il pezzo, una pubblicità commissionata proprio dalla Chiesa di Scientology, proponeva in chiave promozionale alcuni dati sul 'culto' ispirato da Ron Hubbard, e dava notizia della sua espansione e della costruzione di nuove sedi. Provocando non poche critiche: la redazione - della quale alcuni membri hanno giurato su Twitter di non sapere nulla dell’articolo, o hanno comunque preso le distanze da questa scelta - ha deciso di rimuoverlo dodici ore dopo e di scusarsi coi lettori. Cosa che non ha evitato comunque inevitabili ironie, tra le quali - più plateale - quella del sito specializzato in bufale The Onion, che ha lanciato un finto advertorial dal titolo «SPONSORED: The Taliban Is A Vibrant And Thriving Political Movement». Ma non è tutto: tra i più gravi errori, fa notare Dean Starkman sulla Columbia Journalism Review, c'è il fatto di aver potenziato la moderazione dei commenti per quel post specifico, cosicché per un certo periodo di tempo l'articolo ha registrato in larga parte feedback positivi o comunque innocui nei confronti di Scientology.
Ad ampliare il discorso hanno provato in molti, cercando di analizzare il motivo di tanto clamore: c'è chi crede che la cosa abbia avuto risonanza perché a esser sventurata protagonista è stata una storica e apprezzata testata; chi pensa sia colpa del tema dell'inserzione, la controversa organizzazione a carattere religioso - «Isn’t an appropriate subject» - a prescindere dalla piattaforma ospitante (che comunque offre questo tipo servizio anche ad altri inserzionisti); e chi, come Charlie Warzel su AdWeek, parla di «vero problema del native advertising», temendo si tratti di un episodio che dovrà insegnare a clienti e media corporation a trattare questo strumento con una certa discrezione, inserendo sponsored feature consonanti al tono del sito, «l'unico modo per avere possibilità di successo» con questo mezzo. Punto di vista che si accoda a quello Shafqat Islam, co-founder di NewsCred, che pone l'accento sulla definizione stessa di native advertising, dato che quella ‘incriminata’, in effetti, non sarebbe affatto da ritenersi tale essendo stata vissuta come estranea (e dunque non native) dai lettori - messi sempre di più a dura prova, come spiegato da Andrews di GigaOM a fine dicembre in un nostro post, dall'operazione di distinzione fra contenuti editoriali e quelli pubblicitari.
La proprietà intellettuale delle foto su Twitter
In questi giorni una sentenza del tribunale di New York ha cercato di fare chiarezza sull'eterna disputa attorno alla proprietà intellettuale delle foto pubblicate su Twitter. Il fotografo Daniel Morel, che ha lavorato nella Haiti post-terremoto nel 2010, ha infatti citato in giudizio l'Agence France-Presse e il Washington Post per aver utilizzato delle sue foto, scattate sull'isola americana e pubblicate sul social network, senza alcuna autorizzazione da parte dell'autore. Le immagini - prese dalla AFP, caricate sul sito di stock Getty Images e da lì rintracciate dal giornale della capitale - sono state riutilizzate dalle due media corporation nella certezza - è questa la tesi difensiva - che una volta caricate su Twitter queste diventino liberamente utilizzabili da chiunque. Non è stato dello stesso avviso il giudice di Manhattan Alison Nathan, che ha accolto il ricorso del fotografo e stabilito che le news agency non possono servirsi incondizionatamente delle foto trovate sul social, in violazione dei diritti d'autore.
Questione che coinvolge temi a più ampio raggio: per la prima volta, infatti, si è assistito ad una decisione di carattere giuridico nei confronti di un caso che nasce e si sviluppa attorno ai contenuti caricati e tratti dai social network. E che resta comunque poco chiaro, perché se è vero che la policy di Twitter, resa nota nel termini di servizio, spiega chiaramente che i contenuti pubblicati sulla propria piattaforma non possono essere considerati utilizzabili da terzi, c'è da considerare il passaggio della decisione nel quale la corte distingue fra la condivisione di prodotti multimediali attraverso pratiche quali il retweet, e il comportamento di agenzie come la AFP, che hanno interpretato - sbagliando - il processo di ripubblicazione come 'licenza' per un loro libero sfruttamento commerciale. «Users own their photo», confermano da Twitter alla Reuters.
Il tema è di fortissima attualità. Sempre in questi giorni, in Inghilterra, si è dibattuto sull'uso fatto da alcune testate di foto tratte da Twitter per la copertura dello schianto dell'elicottero a Londra: «La velocità con la quale i media utilizzano testimonianze fotografiche non sorprende data la natura di questa storia, ma solleva questioni in merito ai diritti d’autore», spiega Lisa O'Carroll sul Guardian. In passato, continua, questo tipo di materiale era generalmente definito user generated content, o citizen journalism, ma con Twitter, adesso, tutti possono e tutto è potenzialmente ‘notizia’, così diventa necessario avere piena contezza dei suoi termini d’uso.
O ancora la questione delle immagini di Reddit utilizzate da BuzzFeed, o l’aggiornamento delle norme di servizio di Instagram: «Questa tensione verso le fotografie è destinata a crescere col crescere della diffusione degli smartphone e delle persone che pubblicano contenuti online» spiega Jeff Roberts su PaidContent, «e allo stesso tempo, queste immagini tratte dai social media stanno diventando sempre più essenziali per il news reporting». «There is no easy solution to this copyright mess», conclude, malgrado il suggerimento di John Herrman su BuzzFeed: «Vuoi pubblicare immagini tratte da Twitter legalmente? Facile, embéddale» (quel procedimento tramite il quale, attraverso il copia e incolla del codice HTML dell'intero tweet nei post, è possibile incorporare la foto dell'autore nel testo e lasciare così che la questione giuridica rimanga, in pratica, competenza della piattaforma di Twitter).
La finta ragazza morta di Manti Te'o
Manti Te'o è il linebacker dei Notre Dame, una squadra di football americano, un ragazzone di origini hawaiane che si è fatto valere in campo e fuori per abnegazione e talento: nel corso del 2012, secondo molta stampa, è persino dovuto scendere in campo nonostante avesse subito pochissime ore prima due dolorosi lutti, la morte della nonna e, a pochi giorni di distanza, quella della fidanzata. Lennay Kekua, malata di leucemia e legata al ragazzo da mesi, sarebbe infatti deceduta in seguito a un incidente stradale in California nel settembre scorso. In settimana, il blog sportivo Deadspin ha però approfondito il caso e scoperto che la ragazza, in realtà, non è mai esistita.
Si sarebbe trattato infatti di una bufala, seguita, pubblicata e mai verificata da numerose testate (qui la storia della sua ‘propagazione’) di rilevanza nazionale e mondiale come ESPN e Sports Illustrated. Secondo molti - tra i quali il Senior Media Reporter dell’Huffington Post Michael Calderone - più che di un caso di negligenza, si sarebbe trattato di una sorta di implicita accondiscendenza nei confronti di una storia che sembrava, così come era stata costruita, altamente ‘notiziabile’, un ritratto commovente sul quale i media si sono fiondati senza eccessiva cura - un atleta che perde la propria ragazza, malata, e decide comunque di scendere in campo. Un «archetipo» perfetto che ha retto per settimane, «perché i media stessi volevano esistesse» - spiega il fondatore di Deadspin. Un caso che «dimostra come i media abbiano aiutato a diffondere falsità che, se verificate, avrebbero rovinato una bellissima storia», precisa Calderone. «È incredibile che queste testate siano state tanto tempestive nel coprire la notizia della morte della ragazza senza alcuna verifica - qualche conferma dall’obitorio, notizie dal funerale, commenti dei familiari».
Il caso, imbarazzante per decine di operatori del settore, ha coinvolto e portato all'errore testate e media di vario tipo: su SB Nation, per esempio, è possibile trovare una lista di coloro che non hanno mai controllato, che comincia - meritoriamente - con «noi» e prosegue con «tu (tranne Jack Dickey e Timothy Burke - gli autori del post di Deadspin)», considerando il tempo che ci è voluto per portare a galla la bufala - più o meno quattro mesi - e che a farlo sono stati comunque degli 'addetti ai lavori' e non dei citizen journalist. Ma la questione tira in ballo ovviamente anche l'etica giornalistica, il dovere della verifica e della condivisione pubblica di più fonti possibili, in modo da riuscire a contestualizzare il proprio articolo e renderlo più ‘forte’: Steve Buttry, per esempio, richiama la accuracy checklist di Craig Silverman, un vademecum che dovrebbe accompagnare il giornalista nella stesura e nella verifica della notizia che sta riportando, e sottolinea l'importanza della pubblicazione dei link e della loro consultazione per evitare altre situazioni del genere (l'unico collegamento nel pezzo di ESPN, nota per esempio, rimandava inutilmente alle statistiche sportive di Te'o). Karen Fratti, su Mediabistro, coglie l'occasione per ricordare quanto nell'epoca del giornalismo digitale sia importante il processo di fact checking: la cura delle fonti, sui social media e non, e l'uso degli strumenti basilari della professione - con un po' buon senso e scetticismo.
Correzioni al Washington Post

Mercoledì scorso, con una mail interna, il Washington Post ha deciso di aggiornare la proprie policy in fatto di correzioni nella versione in rete del giornale, una serie di norme codificate «nell'intenzione di assicurare che gli errori online siano corretti il più velocemente possibile». Si va dalle formule da usate per le semplici correzioni - da allegare in coda o all'inizio dei post, in base alla gravità dell'errore - al divieto di rimuovere dalla rete articoli già precedentemente pubblicati. «Nel qual caso», precisa il memo, il pezzo «verrà sostituito da una nota che spiega le ragioni della rimozione» - sebbene Craig Silverman, su Poynter, si dica lievemente scettico sulla cosa, a giudicare dall'esempio riportato nella mail per situazioni come quella descritta: adottare la gustificazione «pubblicato inavvertitamente», che non sarebbe in grado di chiarificare effettivamente le ragioni dell'annullamento.
Intanto la testata martedì scorso ha sospeso il redattore capo della redazione messicana William Booth, dopo che lo stesso giornalista ha ammesso di aver copiato illegalmente quattro passaggi dalla rivista accademica Environmental Health Perpective, utilizzati per un articolo a proposito dell'estensione del canale di Panama apparso comunque il 12 gennaio scorso con una editor's note di scuse. «È policy del Post quella per cui l'uso di materiali da altri giornali o fonti debba essere adeguatamente accompagnato dal rimando alla fonte originale», spiega l'avviso della testata, che ha assicurato di prendere in seria considerazione il caso e ha preteso le scuse pubbliche del giornalista - che comunque si è detto profondamente dispiaciuto ma si è difeso spiegando che non ha agito intenzionalmente.