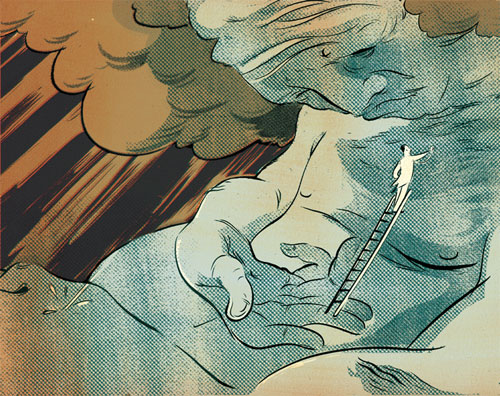Questa settimana in RoundUp: quanto è importante per i giornalisti digitali imparare a "sporcarsi le mani" con programmazioni e codici? E i miliardi dei signori dell'industria tecnologica riusciranno a salvare il giornalismo?
È proprio necessario imparare a programmare?

Nel mondo del dibattito mediatico, questa settimana è stata soprattutto quella della ONA Conference di Atlanta (incontro annuale organizzato dalla Online News Association) e dei trend che da questa sono emersi. Come già riportato da Andrea Iannuzzi, grande rilievo è stato riservato al ruolo dei dati, delle tecniche informatiche, dei numeri in generale, e più in particolare alla necessità da parte di vecchie e nuove leve del mestiere di apprendere le tecniche di programmazione, i codici che servono a costruire un sito, implementare strumenti multimediali nei propri articoli (dall’html di base a JavaScript). Una tendenza che trova conferme da più parti, come sintetizzato da Frederic Filloux su Monday Note: [tweetable]il giornalismo ‘classico’ è ormai estinto, le abitudini dei lettori sono cambiate[/tweetable] e variano in base al device utilizzato e al momento della giornata nel quale lo si consulta: le notizie devono essere lì, attraenti per pubblico e investitori, diverse per tutte le esigenze e declinabili su ogni mezzo. In pratica, bisogna imparare a parlare più lingue, e capire qual è il modo migliore per raccontare le proprie storie - spiega il media consultant Mario R. Garcia sul proprio blog.
Sulla necessità di imparare a programmare e a intervenire manualmente sui codici, l’articolo più discusso di questa settimana è quello di Olga Khazan su The Atlantic. La sua è infatti una presa di posizione critica e netta che cerca di trovare una ‘falla’ in questa ormai popolare e incrollabile credenza: chi ha intenzione di diventare giornalista, spiega, farebbe bene a impiegare il proprio tempo cercando uno stage, collaborando come freelance, imparando a scrivere e a stare in una redazione, piuttosto che a lavorare con degli strumenti che, nella maggior parte dei casi, non vale quasi la pena di conoscere e che possono comunque essere utilizzati in maniera semplificata grazie ai numerosi strumenti reperibili online. Cosa tanto più vera - continua - se si aggiunge che nelle redazioni ‘moderne’ si tende sempre più spesso a settorializzare il lavoro assegnando a ogni membro o team una specializzazione («come video, grafici interattivi») e rendendo inutile la necessità di imparare a fare più cose rischiando di penalizzare un aspetto fondativo del mestiere (scrivere). Il punto di vista di Khazan è in un certo senso riassunto da Evgeny Morozov su Twitter: [tweetable]«Per insegnare a tutti a programmare non dovremmo prima insegnar loro a scrivere?»[/tweetable].
«È il 2013: stiamo ancora qui a parlarne?»
Le reazioni all’articolo di The Atlantic sono state numerose, tutte concentrate [tweetable]sulla necessità di insegnare nelle scuole di giornalismo - e di imparare per chi già esercita - a programmare e «sporcarsi le mani» con numeri, applicazioni e stringhe[/tweetable] (Mark Hansen della Columbia Journalism School, ripreso da Capital New York). Steve Buttry sul suo blog spiega quali sono secondo lui le ragioni per le quali sarebbe fondamentale aprirsi a nuove forme di produzione e all’apprendimento di nuovi metodi di lavoro come quello del coding: [tweetable]le carriere giornalistiche sono ormai imprevedibili e le nuove leve devono avere una formazione «a tutto tondo»[/tweetable], non potendo sapere quale sarà il loro futuro, cosa vorranno fare della propria carriera, quale sarà il prossimo scenario mediatico. È necessario ‘brillare’ rispetto all’offerta media - è il suo suggerimento -, costruire un curriculum che spicchi sugli altri, offrire competenze diverse da quelle ormai alla portata di tutti. Più conciliante la tesi di Robert Hernandez della USC Annenberg su NiemanLab: «Sono d’accordo sul fatto che non tutti i giornalisti debbano necessariamente imparare a diventare dei maestri di Javascript, Python, o Ruby», ma è comunque fondamentale - continua - che sappiano di cosa si tratti, che riescano a capire cosa stia dietro l’impalcatura di un pezzo o di un intero sito quando va online, riuscire a mantenere un grado di alfabetizzazione digitale adeguato così da riuscire anche a comunicare meglio con i propri collaboratori. [tweetable]«È il 2013: davvero siamo ancora qui a dibattere sull’importanza delle conoscenze tecnologiche?»[/tweetable].
[tweetable]«Un digital journalist (o web journalist) deve concentrarsi sul produrre giornalismo del web, non solo sul web»[/tweetable], continua Hernandez: si può manifestare in diversi modi, ma attraverso strumenti che si devono conoscere - o quanto meno ‘masticare’ - quasi tutti. Il tema della «technological literacy» è una delle tesi fondanti del parere di Noah Veltman di Knight-Mozilla OpenNews: è necessario imparare a parlare e lavorare col linguaggio del web anche per continuare a spendersi con strumenti nuovi nella ‘missione’ che è data al giornalismo, e che oggi si presenta sotto forma di nuove sfide - decifrare dati complessi, renderli leggibili al più vasto pubblico possibile per non minare le basi della democrazia informata. Veltman spiega comunque che non si può assumere come assoluta la tesi «ogni giornalista deve imparare a programmare», né quella opposta («Journalism is not a monolith»). Dadid Holmes, per rispondere alla ‘domanda binaria’ «Should you learn to code?», ha costruito un diagramma di flusso.

I miliardari digitali salveranno il giornalismo?
Che sia un citizen journalist che pubblica i propri contenuti su CNN iReport, un redattore della mobile app Circa o un reporter del New York Times, è chiaro a tutti che ci troviamo ormai a una nuova definizione di giornalismo - spiega Jonathan Peters su PBS Mediashift. Un ruolo nuovo, più elastico, che tuttavia pretende - come visto - una definizione univoca in termini professionali, quando non legislativi. Ma se le piattaforme di consultazione cambiano, così come cambiano le pretese dei lettori e i metodi di produzione in continua evoluzione, non è lecito pensare al giornalismo stesso, in termini storici, come a una professione sia ormai antistorica? [tweetable]Davvero il giornalismo è obsoleto?[/tweetable] È la teoria dell’esperto di new media George F. Snell, che si domanda se da qui a 10-20 anni possa ancora esistere questo tipo di figura nel panorama mediatico - non a caso, precisa, negli Stati Uniti ci si trova di fronte al più basso tasso di unità impiegate nel giornalismo dal 1978 a oggi. La tesi di Snell si sviluppa attorno a una delle notizie della settimana, l’assunzione del columnist del New York Times David Pogue come Content Marketer di Yahoo: Pogue è solo l’ultimo di una schiera sempre più numerosa di professionisti del settore che entra a far parte di corporation di vario genere (Dan Lyons da Forbes a HubSpot, Ben Worthen dal Wall Street Journal a Sequoia Capital, ma anche l’addio di De Rosa a Reuters e il recentissimo arrivo di Vivien Schiller a Twitter cone Head of News). [tweetable]«Stiamo assistendo al declino della professione giornalistica?»[/tweetable], si chiede l’autore. E davvero tutte le company si stanno già attrezzando per diventare «media company»?
Di certo il giornalismo (e non i giornali per sé), per quello che rappresenta in termini commerciali e sociali, continua a essere una forte attrazione anche per i lord dell’industria tecnologica. «You cannot launch a successful modern media company without technology as an equal partner» spiega Kenneth Lerer, imprenditore che ha investito su prodotti come Huffington Post e BuzzFeed, e in queste ultime settimane alcuni eventi hanno effettivamente dato il senso di quanto «le fortune e le idee del settore tech» si stiano dirigendo verso quello delle news: è il tema di un articolo di David Carr di questa settimana, che parte dal futuro progetto editoriale finanziato dal fondatore di Ebay Pierre Omidyar (di cui abbiamo parlato la scorsa settimana) e dell’investimento di 250 milioni di Jeff Bezos nel Washington Post. Sono solo due, spiega Carr, dei sempre più numerosi esempi del genere (a cominciare da Laurene Powell Jobs con Ozy Media e Chris Hughes di Facebook con The New Republic). Secondo Omidyar l’intento - quanto meno il suo - è entrare nel mercato dei contenuti per trovare una via profittevole e duratura per informare la più vasta platea possibile e «servire l’interesse generale in un modo commercialmente sostenibile». L’industria tecnologica è forse l’unico settore che può farcela, in sostanza, ma la domanda più ricorrente in questi mesi è sempre “riusciranno i miliardari digitali a salvare il giornalismo?”.
Quando il ‘nuovo’ stenta a decollare

Se è vero che l’approccio digitale a questo mercato può rappresentare una speranza in termini d’investimenti e idee, per quanto riguarda l’offerta si fa ancora fatica a capire quale sia la strada più conveniente da percorrere. A tre anni dal lancio dell’iPad, che ha aperto a un intero settore di contenuti e lettori nuovi, i prodotti per tablet faticano ancora a imporsi come alternativa credibile: la readership di magazine per tablet rispetto a quella totale rappresenta ancora il 3,3%, e persino il top selling del settore Game Informer, che ha raggiunto ai suoi massimi una diffusione di 3 milioni di copie digitali, comincia a conoscere una leggera crisi. Il problema, spiega Lucia Moses in un lungo articolo su AdWeek, non è lo strumento ([tweetable]entro il 2017 gli utenti tablet passeranno infatti da 128 a 160 milioni[tweetable]), ma è probabilmente l’idea di un contenuto ‘chiuso’, tutto sommato ‘stampato’ seppure su un altro strumento, poco attrattiva per il lettore e per il settore pubblicitario. La bassa interazione, la tendenza ormai naturale alla lettura in tempo reale e la condivisione con i propri contatti, farebbero di questo tipo di lettura un’esperienza quasi obsoleta: app come Flipboard, suggerisce l’articolo, sfruttano questa esigenza aggregando contenuti e connessioni social, riuscendo a portare i propri iscritti a più di 90 milioni - seppur incontrando non poche ostilità, come quelle di Wired e New Yorker.
Anche il sistema del native advertising, altro trend degli ultimi tempi (di cui abbiamo già ampiamente parlato), sta cominciando a incontrare le prime incognite. Date per note le difficoltà degli utenti (in ragione del fatto che questo tipo di contenuti commerciali appare in modo del tutto simile a quelli editoriali), sarebbero anche le agenzie pubblicitarie stesse a incorrere in più di un dubbio e a esitare fortemente su questo tipo modello. C’è da superare la difficoltà di collaborare a stretto contatto con le redazioni giornalistiche, stare «nella stessa stanza» - come si legge sempre su AdWeek -, ma ritrosie arriverebbero anche dall’altro versante, quello dell’inserzionista. Molti dei clienti, che pagano per un’inserzione funzionale, efficace, di sicuro impatto, preferiscono ancora andare ‘sul sicuro’ e investire su prodotti più classici: dobbiamo renderlo «più facile da capire per i nostri inserzionisti», spiegano dal reparto Digital Ad di Time Inc, ed è una necessità urgente se si pensa al fatto che già adesso il 73% dei membri della Online Publisher Association offre a clienti e agenzie - non del tutto soddisfatte - prodotti pubblicitari votati proprio al native advertising.
(Seconda immagine via)