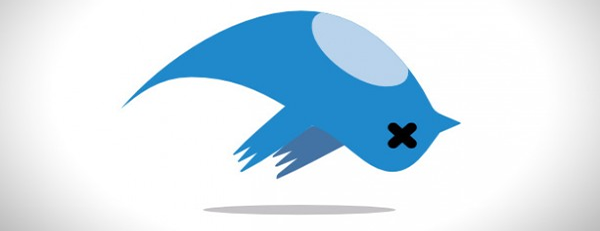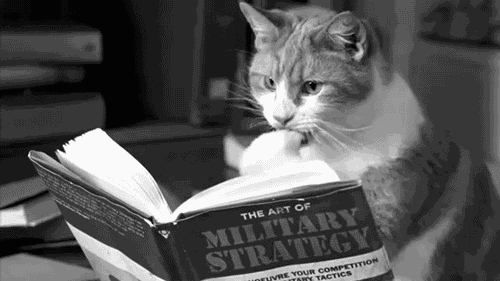Questa settimana in RoundUp: Matt K. Lewis confessa su The Week di «odiare» Twitter, provocando dibattiti e reazioni più o meno ironiche; una rassegna di NiemanLab sulle ultime ricerche accademiche in tema di media digitali; gli articoli sono sempre più corti, malgrado i primi esperimenti di slow journalism multimediale; il New York Times - e non solo - sotto l'attacco di hacker cinesi.
«Perché odio Twitter»
Uno degli articoli a tema mediatico sui quali si è più discusso questa settimana in rete è stato «Why I hate Twitter» di Matt K. Lewis su The Week. Esasperato dal «chiasso» di Twitter, diventato ormai una sorta di «luogo oscuro», Lewis spiega quali sono le ragioni che lo hanno portato a considerare il social network una specie di «prigione», impossibile da abbandonare per motivi professionali, apprezzata agli esordi ma che col passare degli anni si è trasformata in una piazza dominata da faziosità e scherzi (e di questo se n'è parlato anche la settimana scorsa), non aggregatore di idee, ma di problemi personali e giudizi sommari - per l'autore insopportabili. Un flusso dentro al quale diventa difficile continuare a servirsi del mezzo per finalità giornalistiche - è Lewis stesso ad ammettere di aver consigliato ad aspiranti giornalisti di fare pratica col mezzo - e che in linea di principio distrae dalla professione, che porta a leggere di - o ad aderire a - «small petty battles» e che assomiglia sempre di più, metaforicamente, al passaggio degenerativo del concetto di ‘amore libero’ tipico degli anni sessanta che avrebbe portato a addirittura produrre, secondo l'autore, personaggi come Charles Manson.
Il post, che ha incontrato qualche inevitabile ironia su Twitter - certificando in un certo senso il punto nodale della critica di The Week, fa notare Julie Moos su Poynter - ha trovato la sua più forte critica in un articolo di Choire Sicha per The Awl. La tesi dell'autore tende a smantellare l'intero impianto argomentativo di Lewis partendo da un presupposto 'tecnico': non può essere Twitter in sé ad aver subito, o condotto, a una degenerazione, trattandosi di un social media sul quale si sceglie liberamente il feed da seguire, e non si subisce - a meno che non lo si voglia - la propria timeline potendo modificarla in ogni momento. Rebecca Greenfield, su The Atlantic Wire, nota infatti come i following di Lewis ammontino a più di 5000, insolitamente numerosi per un professionista della comunicazione, molti dei quali apparentemente superflui e 'eliminabili'.
«Se non puoi smettere di seguire persone di cui non ti importa, o bloccare persone che ti disgustano, allora hai bisogno di andare in terapia», taglia corto Sicha. La ‘difesa’ del mezzo, che viene comunque da un utente non particolarmente - e notoriamente - entusiasta, non fa a meno di stigmatizzare l'accostamento free love generation-Manson con Twitter. E, com'è nello stile beffardo di The Awl, prendersi gioco dell’autore criticato: «Quasi tutto quello che si consuma su Twitter avviene perché lo si sceglie. E se non riesci a vivere senza ciò che tu stesso hai fatto, dovresti fare come Matt K. Lewis e lasciarlo. Allora sarai al sicuro. Fino a che non ci scrivi un pezzo. E tutti si prendono gioco di te su Twitter». Il dibattito si chiude in qualche modo con la replica, sempre su The Week, di Paul Brandus che spiega invece le ragioni del suo amore per il social network di San Francisco (fonte, media, ispirazione, ottimo strumento per chi intende fare del giornalismo senza opinioni).
Ricerche accademiche sui media digitali
Questa settimana su NiemanLab è stato pubblicato un articolo curato da Journalist's Resource - un progetto dello Shorenstein Center su media e scienze sociali - che cerca di fare un quadro delle ultime ricerche accademiche in tema di media digitali. In uno scenario caratterizzato dal mobile, è ovviamente Twitter a esser preso a protagonista di più di una ricerca. Quella dell'Università di Sheffield si concentra sul carattere del social media come strumento di diffusione di breaking news, a partire dall'esperienza di Paul Lewis (The Guardian) e Ravi Somaiya (New York Times) durante i London riots del 2011: diverse le loro strategie 'editoriali' nell'uso del mezzo, diverso il feedback, in un contesto che impone nuove norme etiche e convenzioni giornalistiche per i professionisti.
Dinamiche che impongono cambiamenti per tutto il settore: è il tema, ancora, di una ricerca dell'Università di Gothenborg, su come internet e le mobile news abbiano ridefinito l'intero contesto, fino a ridisegnare anche il profilo dei consumatori. Uno studio della New School for Social Research parla di «produsage», una buzzword recentemente utilizzata per indicare l'annullamento della distinzione netta fra produttori (media) e consumatori (audience): è l'emergere di un nuovo attore producer-consumer in grado di 'abitare' entrambe le sfere e partecipare a un rinnovato mercato dell'informazione, cui è possibile tracciare una silhouette in base ad alcuni dati empirici ('semplici' lettori gli utenti sotto i mille tweet, area del produsage fra gli 8000 e i 25 mila messaggi).
Ancora, una ricerca della Hebrew University di Tel Aviv si è concentrata, analizzando i dati di venti paesi, sull'influenza dei contesti politici sull'attività sui social network durante la cosiddetta Primavera Araba. E infine, non pochi i riferimenti a conseguenze, dilemmi etici e paradossi dell'incontro tra vita digitale e non, con l'approfondimento su ciò che accade ai profili Facebook dopo la nostra morte (Pepperdine Law review), sull'universo non profit al tempo dei social media, con ovvio riferimento al caso «Kony 2012» (Non-profit and voluntary sector Quarterly) e le implicazioni derivanti dal futuro dei mobile visual device, come il noto progetto Google Glass (Boston University).
La lunghezza degli articoli e lo slow journalism
In questi giorni ha preso corpo anche un dibattito sviluppatosi attorno ad alcuni dati diffusi dalla Columbia Journalism Review («Major papers' longform meltdown») in merito al crollo degli articoli in formato longform nell'editoria americana, alle prese - queste sarebbero le cause - con riduzioni del personale e adeguamento a nuovi strumenti di lettura (e di offerta delle news in generale): meno 86% per i pezzi superiori a 2000 parole dal 2003 al 2012 sul Los Angeles Times, per esempio, meno 50 al Washington Post, 35 e 25% rispettivamente per Wall Street Journal e New York Times (qui alcuni grafici). Un tracollo che secondo Alan D. Mutter ha sconvolto forse eccessivamente gli esperti del settore: gli 'addetti ai lavori', i principali consumatori di giornali - spiega -, tendono 'ancora' ad associare lunghezza e importanza dell'articolo, del soggetto o dell'autore. Mentre invece, al contrario, oggi è possibile raccontare meglio una storia, un dato, un'intervista attraverso mezzi nuovi, o comunque diversi, che non siano basati esclusivamente sulla 'parola', ma che possano essere declinati anche da video, infografica, esperimenti multimediali.
Un caso da citare, in questo senso, è quello richiamato da Evan Osnos giovedì scorso sul sito del New Yorker: l'esempio è quello del progetto Out of Eden Walk, un portale costruito sul viaggio attorno al mondo di Paul Salopek, che contiene foto, audio, mappe, grafici, che verrà raccontato attraverso Twitter nella sua immediatezza e che ovviamente ospiterà articoli in stile longform che l'autore stesso ha voluto definire slow journalism. Comunque, contenuti per i quali debba valere la pena della lettura: è il punto di vista sull'argomento di Steve Buttry, che suggerisce di concentrare l'attenzione sul valore dell'articolo in sé, piuttosto che sulla sua lunghezza, e sulle esigenze del pubblico: in rete, per esempio, esperimenti come Longreads e Grantland hanno saputo trovarsi una propria stabile platea, e non mancano esempi - come quello di The Atlantic - nei quali la parola 'lunga' non viene disdegnata (qui un esempio di questi ultimi giorni). Ma soprattutto - precisa - dalla rete arrivano i dati su letture e condivisioni degli articoli. Ed è a quelli che bisognerebbe guardare, conclude Buttry: «We should try to write the types of stories that people are going to want to share and read. That's way more important than worrying about how long or short a story is».
Gli hacker cinesi invadono il New York Times
Il New York Times ha subito attacchi di hacker cinesi per ben quattro mesi: a darne notizia è la stessa testata americana, secondo la quale le prime infiltrazioni risalirebbero al periodo in cui il reporter David Barboza ha indagato e poi pubblicato un articolo di inchiesta sulle fortune occulte del premier cinese Wen Jiabao. L'attacco, che è stato quindi ricondotto all'ottobre scorso, avrebbe comportato la perdita di password e dati sensibili di giornalisti e impiegati del giornale con l'obiettivo di individuare i nomi di coloro che hanno collaborato con Barboza nella realizzazione dello scoop.
Le accuse del New York Times, abbastanza precise e comunque smentite categoricamente da Pechino, sarebbero motivate da uno studio condotto da esperti di sicurezza informatica assunti dal giornale, che avrebbero fatto risalire il modus operandi degli ‘infiltrati’ a quello degli attacchi informatici dell'esercito cinese.
Ma il Times non sarebbe stato la sola vittima (qui una breve storia di attacchi informatici nei confronti di testate giornalistiche, qui la puntuale versione satirica di The Onion): anche il Wall Street Journal, così come Bloomberg Business, ha rivelato questa settimana di esser stato vittima dell'attacco di cinesi intenzionati a sorvegliare la copertura del giornale sugli affari di Pechino, una sorta di programma di controllo della stampa americana che registra episodi sempre più numerosi, dal 2008 ad oggi, e che secondo l'FBI - fonte lo stesso Journal - sarebbe da considerare un caso di minaccia «alla sicurezza nazionale contro l'interesse degli Stati Uniti». Come fa notare Ryan Chittum su CJR, in epoca di iper-connessioni, dove nulla è davvero sicuro, la vera domanda è "chi non ha subito un attacco hacker da parte della Cina?".